
Il Vaticano e il caso Viganò, non ci sono più scismi di una volta

La si credeva una parola ormai relegata nella remota realtà storica dei momenti più inquieti del Medioevo, e invece eccola qua, quanto mai attuale e ricca di implicazioni decisamente contemporanee. La parola in questione, e più ancora il concetto che essa definisce, è scisma. La Storia della Chiesa è punteggiata di fratture e dissociazioni appunto scismatiche, che allora come evidentemente oggi, rappresentavano e rappresentano una sorta di crimine, di lesa maestà, addirittura di peccato. Lo scisma dei nostri giorni è ormai troppo noto per soffermarci più di tanto su di esso: monsignor Carlo Maria Viganò, da sempre critico nei confronti di Papa Bergoglio, dovrà apparire di fronte, se non al Tribunale dell’Inquisizione, perlomeno al Dicastero per la Dottrina della Fede perché il suo dissenso ha ormai assunto le caratteristiche appunto dello scisma. Per sua fortuna non rischia più il rogo, quanto piuttosto la scomunica.

"Scisma", Viganò sotto processo. Le accuse a Bergoglio e il pugno duro del Vaticano
È bene che dell’analisi squisitamente religiosa di quanto accaduto se ne occupino i teologi, o perlomeno i vaticanisti, certamente più capaci di chi scrive di orientarsi nei meandri della Giustizia d’Oltre-Tevere. Ma qualcosa in merito forse potrebbe dirla anche chi non può fare a meno di prendere atto del fatto che la Chiesa, oltre che in quello squisitamente religioso, è protagonista anche nell’ambito sociale, politico, ideologico e culturale della società in cui opera. Non sono pochi i miei colleghi, amici e conoscenti che il mio attaccamento alla Rivoluzione Ungherese del 1956 lo considerano un po’ maniacale, e forse non hanno tutti i torti. Tuttavia l’Ottobre Magiaro, considerati gli eventi che lo caratterizzarono e soprattutto ciò che ne è stato detto, non detto e falsificato negli anni e nei decenni successivi al suo divampare, è sempre stato e continua ad essere per me una sorta di cartina di tornasole di cui non riesco a fare a meno per analizzare eventi, personaggi, opinioni, situazioni anche e soprattutto attuali. Lo scisma di monsignor Viganò non fa eccezione.
In quel 1956 il Cardinale József Mindszenty, Primate d’Ungheria e riconosciuto dai combattenti-della-libertà di allora come guida spirituale della Rivoluzione dopo la sua liberazione dalla prigionia impostagli dal regime nazista e confermata da quello comunista, trovò rifugio nell’ambasciata americana quando l’Armata Rossa invase il Paese e soffocò nel sangue la ribellione.
In quegli stessi giorni l’arcivescovo Giovanni Battista Montini portò la croce dell’Ungheria soggiogata in processione per le vie di Milano alla luce delle fiaccole, esprimendo così il dolore e la solidarietà della Chiesa Cattolica e del popolo italiano nei confronti della martoriata nazione danubiana. Mindszenty, pur nel suo esilio nella legazione statunitense, continuò ad essere un punto di riferimento per gli ungheresi ricondotti al ruolo di sudditi di Mosca, tanto che quando, nel 1957, il leader sovietico Krusciov volle tenere un comizio in quella stessa piazza di Budapest dominata dall’Ambasciata Usa, gli occhi di tutti i cittadini che avevano dovuto obbedire all’ordine di presenziare alla trionfale concione, piuttosto che sull’oratore erano rivolti verso una particolare finestra di quell’edificio.

Scomunicate le suore "cioccolatine": le clarisse spagnole si erano ribellate alla Chiesa
Parecchi anni dopo, nel 1971, quello stesso Montini, diventato Pontefice con il nome di Paolo VI, rappresentante dunque di una Chiesa che aveva archiviato la scomunica dei comunisti decretata dal suo predecessore Pio XII, e che stava piuttosto cavalcando l’onda del dialogo, del riavvicinamento, del compromesso e della così detta Ostpolitik, ordinò all’illustre prigioniero di lasciare Budapest. Deciso a non abbandonare il suo ruolo di testimone vivente della resistenza all’oppressione, Mindszenty tentò di opporsi all’ordine del Vaticano, ma alla fine, forse anche per il voto di obbedienza che impegna il clero cattolico, dovette raggiungere prima Roma e poi Vienna.
Sempre in quel lontano e opportunamente dimenticato 1956, il giovane deputato comunista Giorgio Napolitano era tra quelli che nell’aula di Montecitorio salutavano l’invasione dell’Ungheria da parte dell’esercito sovietico al grido di «Viva l’Armata Rossa!»
Quando Napolitano morì, poco meno di un anno fa, dopo aver ricoperto tra l’altro il ruolo di Presidente della Repubblica, Papa Francesco, evidentemente a sua volta dimentico di un’innegabile complicità se non altro morale in crimini contro l’umanità, rese un commosso omaggio alla salma evitando tuttavia di farsi quel Segno della Croce che, per un sacerdote, dovrebbe essere, in tali circostanze, una normale e convinta prassi.
È il caso di dire che non ci sono più gli scismi di una volta, basati magari sulla negazione dell’Immacolata Concezione o piuttosto sul disconoscimento dell’autorità e dell’infallibilità del Papa Re, ma forse ancora oggi, come nei secoli passati, le radici e le motivazioni di uno scisma sono altrettanto profonde, complesse e sentite. E certamente non limitate al contrasto tra due e solo due esponenti del clero, come Papa Bergoglio e monsignor Viganò.
Dai blog

Generazione AI: tra i giovani italiani ChatGPT sorpassa TikTok e Instagram

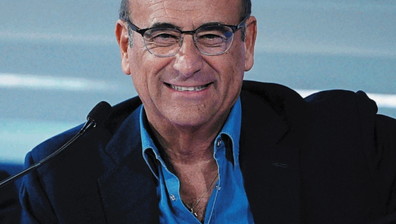
A Sanremo Conti scommette sui giovani: chi c'è nel cast


Lazio, due squilli nel deserto




